La parola: una via di liberazione
di fra Francesco Chillari, Ofm
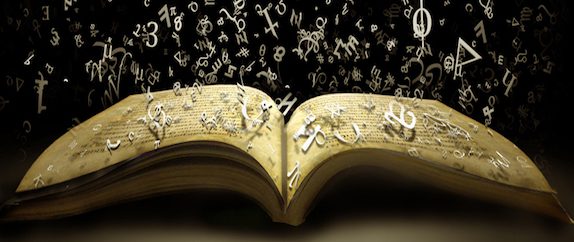
Quando nei nostri ambienti si parla di parola, il riferimento immediato è alla Parola di Dio, alla Sacra Scrittura dunque. E la Parola di Dio ha di per sé un potere liberatorio, taumaturgico, terapeutico. C’è però anche un’altra parola, quella dell’uomo, quella che ciascuno di noi comincia a udire sin dalla nascita e che apprende nel corso della propria esistenza, quella che diventa giorno dopo giorno la veste del proprio linguaggio. Tale parola possiede anch’essa un potere liberatorio, taumaturgico, terapeutico. È questo il messaggio centrale di Come pietra paziente, film afghano del 2013, tratto dal romanzo di Atiq Rahimi Pietra di pazienza (vincitore del Premio Goncourt, 2008). Come pietra paziente è una singolare opera dal carattere intimista. Le sofferenze e le torture di una donna prigioniera del rapporto col marito e della condizione femminile in cui è cresciuta sono trattate con magistrale delicatezza e con sprazzi commoventi di poesia. In mezzo alle bombe e a pericoli sempre maggiori la protagonista del film (che non ha un nome, quasi a voler rappresentare la condizione femminile afghana) compie un autentico e coraggioso cammino di liberazione dalla schiavitù psicologica, confessa al marito di aver sempre disprezzato e odiato la sua prepotenza e si riprende i desideri e le passioni di donna. Come pietra paziente è un viaggio deciso negli abusi culturali che privano la donna della sua dignità, della libertà di scelta, della facoltà di sperimentare la dimensione autentica e consapevole della propria femminilità. A fare da sfondo alla triste e commovente storia della protagonista sono alcuni elementi che, purtroppo, ancora oggi sono all’ordine del giorno nella cultura afghana: un radicato senso di ingiustizia, il degrado culturale e sociale di un ambiente che attribuisce a pochi uomini e alla guerra la dimostrazione di un valore intangibile. La protagonista palesa una condizione femminile dal duplice volto: da un lato la donna sente di essere legata, vicina, al marito, certamente a causa di un legame culturale imposto, ma anche come risultato di un legame affettivo; dall’altro lato, la donna, scendendo nella profondità di se stessa, comincia a capire cosa gli è stato negato e cosa gli è stato impedito di essere in nome della presunta superiorità del sesso maschile. Una lotta, si direbbe, tra due opposti mondi: quello di una donna che nutre la speranza che al risveglio quell’uomo possa davvero diventare suo marito in un legame di amore e rispetto, di libertà e dialogo; e quello della stessa donna che vuole gridare la sua femminilità e il suo essere una persona, cose che finora le sono state negate e dal marito e, soprattutto, dal contesto culturale in cui è nata e cresciuta. «L’immagine di sé risvegliata, lo slancio di vivere una sessualità finalmente condivisa, l’esempio di una zia che è riuscita a sottrarsi al ruolo di oggetto passivo compongono un quadro in cui la pietra umana paziente ascolta rivelazioni sempre più inconciliabili con la realtà vissuta fino ad allora: i figli della coppia sono di un altro uomo – il marito era sterile ma l’assenza di figli sarebbe stata imputata alla moglie e con gravi conseguenze, perciò si era reso necessario provvedere clandestinamente alla risoluzione del problema – e ogni pensiero della donna è ormai lontano dalle costrizioni del passato» (Gianluca Frazzoni). La protagonista fa i conti con una immagine di sé completamente sconosciuta, un coraggio, una caparbia, un desiderio, un’audacia, una tenacia del tutto privi di un riscontro con ciò che era stata fino ad allora. La donna scopre la bellezza della parola, da sempre incarcerata al centro del proprio stomaco dove è diventata come un ammasso di pietre aride, morte, scopre il fascino e il sapore di dire se stessa, di dare voce a quei silenzi che fino ad allora hanno solo gridato nel suo stomaco. Si riscopre così diversa, così audace, da come ella stessa si era conosciuta da pensare, ad un certo punto, di essere posseduta. La protagonista, pian piano, fa l’esperienza di non appartenersi più, di essere sciolta dalle catene di una schiavitù culturale che era diventata oramai la sua stessa identità, di non appartenere più a un tempo che l’ha ridotta solamente a genere (femminile) e corpo. E scopre anche il coraggio della libertà religiosa. Ad un certo punto – nel romanzo questo è molto più evidente – la donna non accoglie più in casa il mullah che la va a trovare solo per propinarle una consolazione senza senso, fredda, senza carità; e trova il coraggio di respirare con un ritmo diverso da quello del marito. Fino ad allora la sua preghiera, sgranata sul rosario, era scandita dai respiri del marito; la donna sa addirittura a quale numero dei respiri del marito passerà il ragazzo che porta l’acqua o quando inizierà a cantare la vicina di casa. Schiava anche del respiro del marito, dunque. Quando la donna inizierà a staccarsi da questi respiri comincerà a trovare in sé, pian piano, la capacità di raccontarsi, di svuotarsi, di liberarsi e lentamente rinascere. Scopre il culto della parola, quella che può fuoriuscire dal proprio cuore e dalle proprie labbra, e diventa profetessa di questo culto. Certamente noi osserviamo la protagonista di questo film con immenso interesse, con trasportante empatia, con grande compassione, condannando il fondamentalismo culturale e religioso dei musulmani. Facciamo nostra la rabbia della donna e di un popolo (soprattutto nella componente femminile) che soffre una terribile schiavitù. Ma spesso questo fondamentalismo che riduce a schiavitù lo ritroviamo anche nella nostra cultura e nella nostra religione, e talvolta anche nelle nostre relazioni interpersonali. In un epoca di delirio digitale, dove la rete, il web, più che strumento per raccogliere (come una rete da pesca) e per nutrirci, diventa strumento che ci imprigiona (come una gabbia) e ci soffoca, dove la parola è ingabbiata, spezzata, ridotta a scheletro senza vita, attraverso sms, chat, dove la relazione ormai e troppo spesso manca di fisicità, di sguardi, di gestualità (come se ci si parlasse separati da un muro), dove anche il significato e il valore dell’amicizia è cambiato ed è così semplice farsi degli amici, in un epoca di tal genere, dentro la quale anche noi cristiani siamo immersi, siamo chiamati ad essere, al pari di questa donna, profeti della parola. Noi che ci diciamo annunciatori della Parola di Dio, dobbiamo essere prima di tutto profeti della parola, di una parola che crea relazioni, che crea dialoghi, confronti, o anche diversità di opinione, o anche litigi. Ma profeti della parola. Profeti di una parola che abbia una durata.«Perché in questo momento la durata è uno dei problemi più grossi nella trasmissione del sapere. Bisogna capire su quale durata puntare, ed è affascinante, e non è facile. [...] Non dobbiamo subire l’idea che ci viene dal web che ormai tutto è pillola: non è vero. La stessa persona che nel web non riesce a stare ferma, che non sente nemmeno più una canzone fino alla fine, questa stessa persona, se preparata, nel senso che le si dice “qui è un altro habitat”, sta un’ora a sentirti, perché non è che hanno più il cervello per farlo» (Alessandro Baricco, Palladium Lectures).Spesso il nostro modo di comunicare, anche con Dio, sta diventando come gli sms che mandiamo, dove per risparmiare non mettiamo le virgole, sostituiamo il per con la x, togliamo le vocali, abbreviamo le parole. Il racconto diventa riassunto. E il riassunto (lo sappiamo benissimo) non contiene la totalità del cuore, ma solo qualche battito, a volte anche mistificato. Consegnarsi nudi attraverso la parola del cuore ci libera. Questa donna ci insegna la bellezza del consegnarsi nuda, la fatica della lotta per consegnare tutta se stessa senza veli, l’audacia di raccogliere luce dalla profondità delle tenebre che ci abitano. Dalle profondità oscure della sua anima, laddove le parole stavano per marcire, la protagonista raccoglie la perla della sua risurrezione. Attraverso il suo raccontarsi la donna attraversa secoli di schiavitù culturale. E li attraversa non camminando in silenzio o calpestando una semplice storia fatta da uomini. Li attraversa dando un nome alle ingiustizie, ai soprusi, alle violenze. Attraversa la storia del suo popolo attraverso la sua storia, quella che le bruciava nell’intestino, quella che la costringe a imprigionare il suo volto dentro un burqa ogni volta che esce di casa (lo vediamo spesso nel film), quella di una donna costretta a sposare una fotografia, un pugnale e che, per tre anni, immagina solamente il suo eroe, quella di una donna costretta ad ingannare il marito facendogli credere che i figli nati dal suo grembo sono suoi, quella di una donna che non sa cosa significa essere donna e che scopre la sua femminilità solo grazie ad un giovane soldato che le restituisce la femminilità perduta. Attraverso la sua autoanalisi la donna sussurra di non voler appartenere più a quel mondo culturale e di voler essere profetessa di libertà. Il coraggio della donna a raccontarsi, a vomitare il macigno che le pesava sullo stomaco, non giunge improvviso, non giunge senza un retroterra che lo prepari. Nel corso della sua esistenza la donna si nutre delle parole e dell’esempio di due personaggi che rappresentano per lei vere e proprie guide spirituali: la zia, una donna con una vita travagliata alle spalle, che però ha saputo gridare la sua libertà, sciogliendosi dalle catene che l’hanno imprigionata; il padre del marito della donna che, purtroppo nel film non compare, un uomo saggio, che ha preso a cuore la donna, guidandola, istruendola, indirizzando i suoi passi, aprendo una leggera via verso una liberazione che poi avverrà veramente. Due figure originali, inconsuete, quelle che la donna sceglie alla stregua di guide spirituali: la zia, una prostituta; il suocero, un uomo, che in quel contesto culturale non è pensabile che assuma un ruolo del genere nei confronti di una donna (fosse anche una figlia). Mi piace molto questo aspetto, perché credo che, nella nostra esperienza spirituale e nel nostro percorso umano, a parlarci del divino o dell’umano possano essere persone anche al di fuori di una buona consuetudine e dagli schemi impostici dalla tradizione. La pietra è destinata a spezzarsi per originare un’esistenza libera, e spezzandosi porterà con sé ciò che ha ascoltato: il coraggio di essere se stessi, anche quando l’essere se stessi mette a rischio la propria esistenza. Un rischio per la vita e per la verità.


